Give a selfie for women at CNR
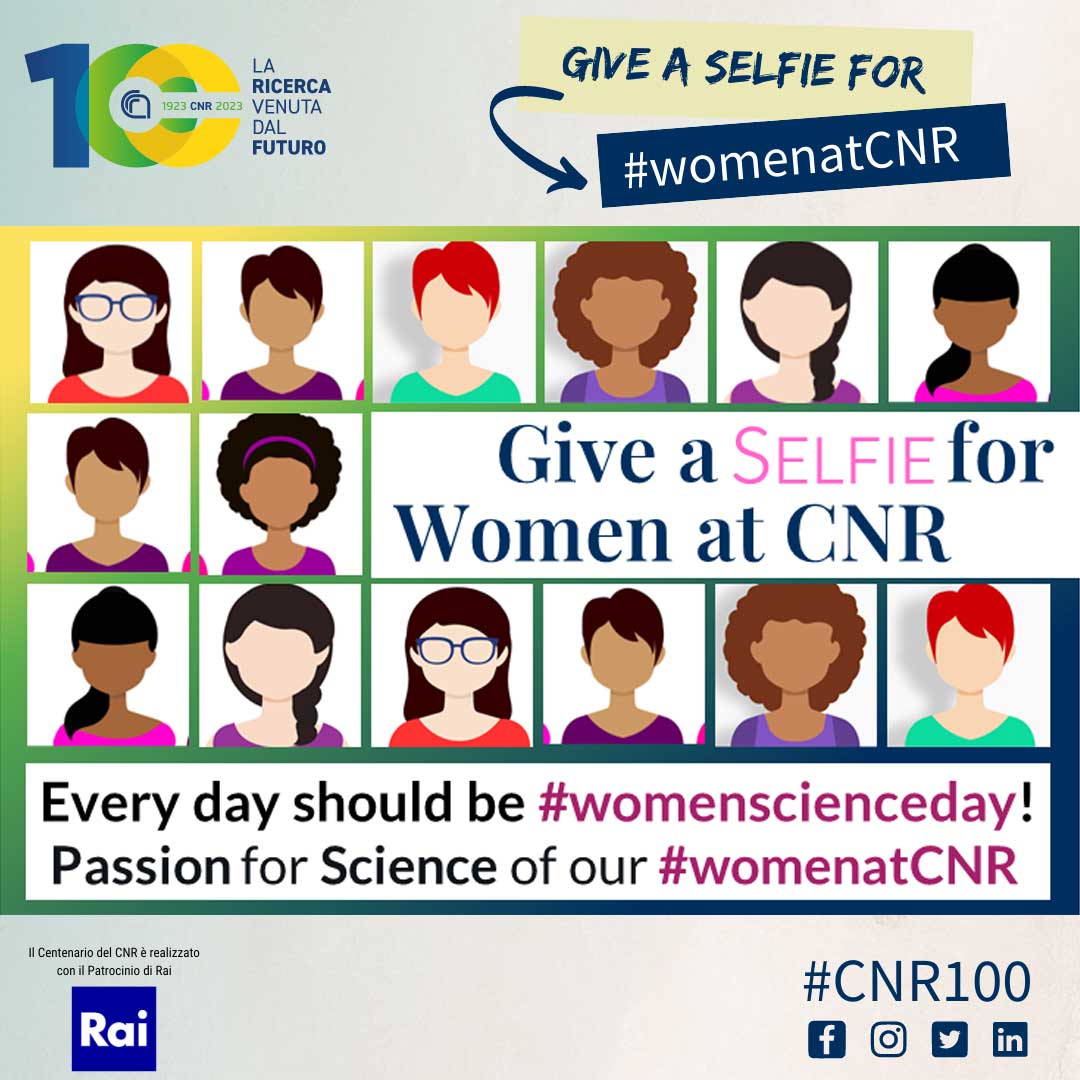 Una staffetta Cnr per celebrare la “Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza” è l’iniziativa che prenderà il via il giorno 11 febbraio 2023 con lo scopo di sensibilizzare e traguardare gli obiettivi per il raggiungimento di parità di genere nella ricerca e nell’innovazione.
Una staffetta Cnr per celebrare la “Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza” è l’iniziativa che prenderà il via il giorno 11 febbraio 2023 con lo scopo di sensibilizzare e traguardare gli obiettivi per il raggiungimento di parità di genere nella ricerca e nell’innovazione.
Tale iniziativa, titolata “Give a selfie for Women at Cnr”’, ispirata da iniziative analoghe di altri centri internazionali di ricerca, è stata inaugurata l’11 febbraio 2022 dall’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Cnr-Scitec) e si è sviluppata come campagna di promozione social con cadenza settimanale con il titolo di “Give a selfie for Women in Science”. Ora, grazie alla partecipazione ed adesione della rete Cnr, ambisce a diventare una vera e propria staffetta virtuale in cui altri Istituti proseguiranno nel lavoro di valorizzazione della comunità al femminile che opera nell’Ente.
L’esperienza del Cnr-Scitec ha dimostrato come l’iniziativa, sostenuta da un’intensa attività di comunicazione trasversale, sia riuscita a coinvolgere molte donne dell’Istituto nell’intento di promuovere i contenuti e le capacità nella scienza e per veicolare un messaggio positivo alle ragazze interessate alle STEM (già diventate STREAM), al grido “Every day should be #womenscienceday”. Al termine del suo percorso comunicativo, semplice ma di impatto, Cnr-Scitec ricompone il mosaico di tutti i volti delle donne che hanno aderito e contemporanemente sostiene la campagna social degli altri Istituti con il lancio dell’edizione 2023.
La ri-partenza viene segnata da un selfie d’eccezione, quello della della Presidente Maria Chiara Carrozza, autorevole testimonianza di donna e ricercatrice a capo di un ente di ricerca, in un anno fortemente evocativo quale il 2023 anno in cui il Cnr celebra il Centenario di vita. A seguito di questo selfie, l’iniziativa si arricchirà dei contributi di molte altre donne afferenti ai diversi Istituti che si riconoscono nell’intento enunciato e che si uniranno strada facendo raccogliendo il testimone.
Le donne che hanno aderito e che aderiranno a questa campagna social sono convinte che lo sviluppo economico, sociale, educativo e territoriale diventi completo se realizzato anche con un contestuale sviluppo della parità di genere nella ricerca e nell’innovazione. Questo pensiero è riportato anche nelle puntuali comunicazioni pubbliche dei vertici degli organismi di finanziamento e di quelli di controllo della ricerca internazionale (https://www.youtube.com/watch?v=nA7YdszDJ_0 – Ursula von der Leyen) oltre che ribadito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La recente introduzione di un piano per la parità di genere (GEP) quale criterio di ammissibilità nei finanziamenti del programma Horizon Europe (2021-2027) e la declinazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione inducono a sostenere tale approccio.
L’iniziativa “Give a selfie for Women in Science 2022” è stata ideata e proposta da Marcello Marelli e Laura Polito, entrambi ricercatori della sede di Milano del Cnr-Scitec. Il materiale raccolto, un “selfie” in lab o alla scrivania con una didascalia per descrivere il lavoro, viene diffuso tramite il sito e i canali social dell’istituto (Twitter e Instagram) con il supporto del Team Social presente su tutta la propria rete territoriale (Milano, Genova, Roma e Perugia), in quanto iniziativa perfettamente aderente alle attività di Terza Missione che l’Istituto ha attivato grazie ad una struttura dedicata.
L’11 febbraio 2023, dunque, il Cnr-Scitec passerà idealmente il testimone dando il via alla staffetta virtuale, per ricordare che every day should be #womenscienceday. Gli Istituti che vogliono aderire, al fine di mantenere omogeneità sia nello stile sia nel format, trovano in allegato un documento con consigli operativi sulle modalità di partecipazione.